
Il rintocco lento di una campana. Nel mezzo di una pianura deserta, un uomo e una donna recitano l’antica preghiera dell’Angelus che, serbando memoria dell’annunciazione recata a Maria, invita a pregare per i defunti. S’interrompe la raccolta delle patate, s’abbandona il forcone, il cesto, i sacchi e la carriola – umili strumenti di nobile lavoro – e si prega. Fasciati nel chiarore dell’ombra i volti dei due braccianti, la tecnica della luce anima il parto dei loro gesti e atteggiamenti. Componendo il tutto in una fragile dolcezza. C’è profumo di raccoglimento. Inizialmente intitolato Preghiera per la raccolta delle patate venne poi ridefinito Angelus con l’aggiunta sullo sfondo di un campanile. Probabilmente Jean-Francois Millet (1814-1875), il pittore che eseguì l’opera su commissione di Thomas G. Appleton nel 1857, non era cattolico: certamente non praticante. A lui interessava parlare del tempo, del riposo, della semplicità esistenziale. Immagine evocativa. Poetica e provocatoria. Forse residuo di una società che, progredendo, s’è discostata da gesti, convinzioni e pensieri lungamente trattenuti nello scorrere del tempo. Tramandati di padre in figlio, il loro eco – partito nella notte dei tempi dei miei antenati – è giunto sino ai miei orecchi quand’ero infante. Fino a cedere oggi alla tentazione di smarrirsi.
Il mondo dei miei antenati, per l’appunto. Dove Dio era così scontato che la sua presenza impregnava ogni realtà: dalla raccolta delle patate, alla strutturazione della società, al parlare con e dell’uomo. Per i miei avi credere in Dio era un assioma e un punto di partenza. Preso per certo, non necessitava di dimostrazioni. Si credeva in Dio e poi in altre cose. E quel quadro ne tratteggia un’evocazione fedele. Dovessimo ri-dipingerlo oggi altri elementi chiederebbero cittadinanza: primo tra tutti un minareto accanto al campanile, o un fedele rivolto ad Oriente appena accanto ai due braccianti. O, magari, si toglierebbero sia il campanile che le moschee perché oggi, diversamente dai miei antenati, credere non è più l’unica opzione: si può anche non credere. Oppure credere e non credere. Che non significa sfrattare Dio bensì ridurne lo spazio vitale. Fino a chiederne i documenti, qualora lo incontrassimo per strada.
Oggi non è facile parlare di Dio. Seduti di fronte ad un pantheon di idoli, sembra esserci posto per tutti e per nessuno: per chi uccide in nome di Dio, per chi vive etsi Deus non daretur, per chi si trastulla al tepore di una funesta indifferenza. La convinzione di Henri De Lubac – «Non è vero che l’uomo possa organizzare la terra senza Dio. E’ vero invece che, senza Dio, non si può che organizzarla contro l’uomo» – è ancora condivisibile nell’era della manipolazione degli embrioni umani, del trasferimento delle cellule embrionali e della clonazione? Per Martin Buber, filosofo ebreo, la parola «Dio» era la più pesante tra tutte le parole umane: imbrattata, lacerata, beffeggiata. Non ammazzata, sembra essere però costretta all’esilio nell’agorà della post-modernità. Ad Amburgo un’ala del cimitero è riservata ai supporters locali: riposeranno in pace in una bara coi colori sociali. Appena fuori Buenos Aires un cimitero speciale – con lapidi, marchio del club e fontana con lo scudetto – è riservato ai sostenitori doc del Boca Juniors. L’uomo della post-modernità non ha sfrattato Dio: ne ha semplicemente ridotto lo spazio cambiando il suo orizzonte di senso. Ha inaugurato un campo di battaglia in cui la fede si trova a fare i conti con la non fede.
Un po’ il dramma che boccheggiava nella parrocchia del curato di campagna di Georges Bernanos dove la volgarità della cultura che respiravano i suoi parrocchiani aveva portato alla crescita di una forma di «cristianesimo decomposto» pur mantenendo salva la fede. Perché «non si perde la fede, essa cessa piuttosto di plasmare la vita». In queste moderne cattedrali le vecchie menti invocano la tradizione. Quelle giovani l’evoluzione e la rivoluzione. Non si tratta di sapere se è meglio o peggio: si tratta di capire chi comanda l’uomo. Fu questo il sogno di quel povero curato che soffriva nel vedere in capo alla salita di Saint-Vaast che la noia divorava la sua parrocchia, quella «specie di litania che si ascolta distrattamente fino a diventare un elemento di sottofondo della nostra vita» (Diario di un parroco di campagna). Il cristianesimo come una sorta di arredamento.
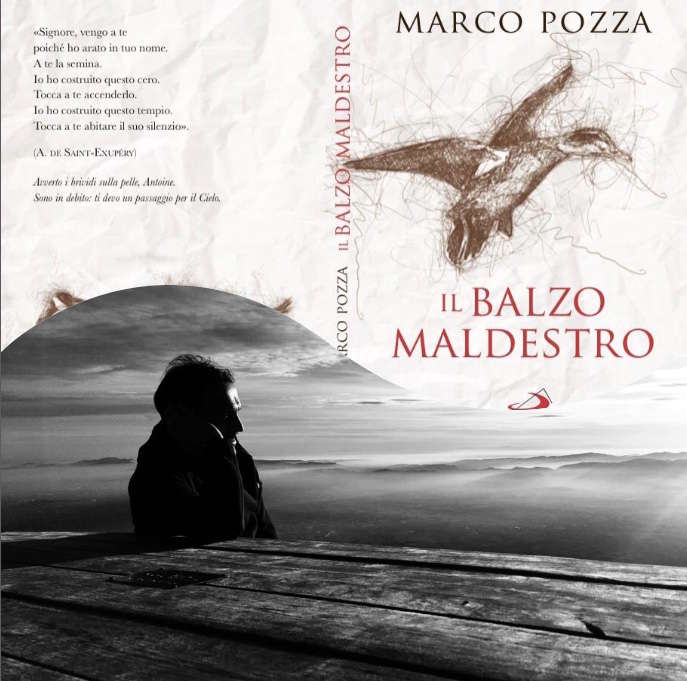
(clicca qui per leggere la scheda del libro e acquistarlo online)



