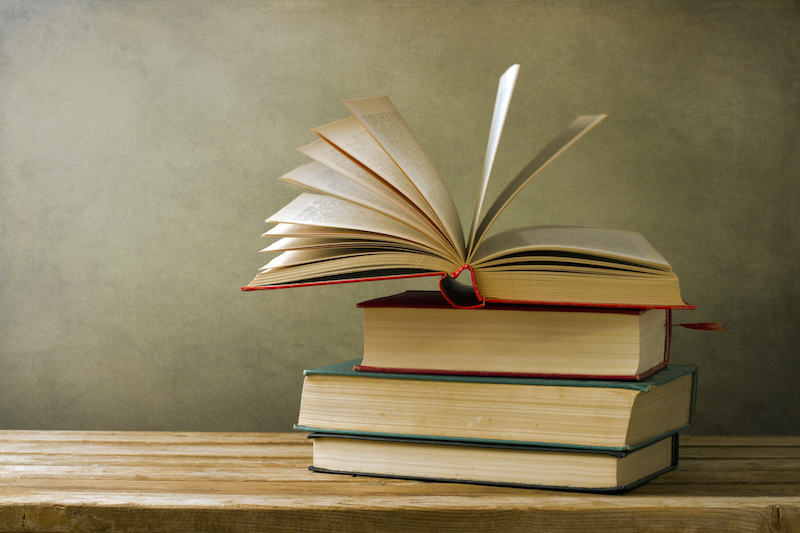
La storia di una nazione potrebbe essere ricostruita benissimo in base alla sua letteratura, dal momento che quest’esercizio-della-parola non è altro che l’esperienza vissuta dall’umano decantata in parole: l’insuccesso, il successo, il dispiacere, la soddisfazione, l’apatia. La letteratura, dunque, come annuncio e minaccia, avvertimento e chiamata alle armi. Compito della parola – e quindi di chi la usa – non è quello di risolvere nessun problema: gli scrittori lanciano la sfida, raramente danno delle risposte, il più delle volte aprono delle finestre su mondi inediti, accettano d’essere voce del particolare nell’universale. E’ per questo che i regimi totalitari guardano di sbieco la letteratura: «Come se tutti i regimi vedessero nella letteratura un pericolo per la loro stessa esistenza. E non sbagliano» (M.V. Llosa) Missione della letteratura è quella di prendere per mano un problema, prestargli la voce, sottoponendolo all’attenzione del grande pubblico. Nessun libro, infatti, termina mai con l’ultima parola scritta dall’autore: solo quando il libro finirà nelle mani di un lettore, potrà dire d’aver raggiunto lo scopo per il quale era nato. I più vivono per scrivere, altri scrivono per vivere.
La maggior parte delle volte la letteratura non parla di Dio. Parla, però, di insuccesso, amarezza, delusione, malinconia, noia: che altro sono se non l’altra faccia della medaglia, quello che un pensatore come Horkheimer definiva la «nostalgia del totalmente altro»? La rarità del parlarne, dunque, potrebbe non essere altro che il modo profano odierno di parlare di Dio, dei suoi misteri. La grande produzione letteraria del Novecento, è tutta attraversata da questo grido verso l’Assoluto: il grido di Cesare Pavese che si uccide ma mentre porta alle estreme conseguenze il suo male-di-vivere grida: «O Tu, abbi pietà!». Ecco, dunque, che certe pagine di letteratura somigliano tantissimo a quei dipinti che non si potrebbero appendere dentro le navate delle chiese: ai più darebbero scandalo, pochi li capirebbero. Eppure quei dipinti, magari, sono più cristiani di un quadro che dipinge Santa Rita senza nessuna carica umana addosso. Così è di certe pagine di letteratura: perlustrando l’uomo, aprono squarci sull’infinito. Come dire: in questi quadri non c’è luce ma, scrutandoli, ciò che sento nascere è il desiderio della luce, d’accendere una luce. Una quasi-seduzione laica delle questioni ultime dell’uomo, a prescindere dal credo religioso: «Si scrive per sedurre con le parole. O si è un seduttore o non si è uno scrittore» annotava Luis Sepulveda. Vera seduzione, però, non è mai un imbonimento: «Si seduce seduce qualcuno per poi procedere mano nella mano».
Il Premio Nobel per la Letteratura, assegnato quest’anno al cantautore Bob Dylan, potrebbe venir letto esattamente così: un riconoscere che le parole – di un poeta, di uno scrittore, di un artista – han dimostrato d’essere seduzione per l’umanità. Quel passo-in-avanti che è valso loro il Nobel è stato l’aver fornito all’umanità l’attrezzatura per meglio valutare la propria posizione nel mondo, quell’essere-nel-mondo ch’è il cruccio di ogni umanesimo: l’ambizione dell’arte è di unificare la persona. Nessuna soluzione, dunque, è mai da chiedere all’uomo ch’è capace di vera letteratura: piuttosto che apra dei processi, che ci ricollochi nella storia in modo diverso da com’eravamo stati abituati. Che ci faccia vedere il mondo nascosto dentro un granello di sabbia, nel battito d’ali di una farfalla. La Grazia nella natura, la bellezza attraverso le brutture, il cielo in una zolla.
Nella scrittura, dunque, campeggia l’ardua sfida di risvegliare l’uomo dal torpore della banalità, proiettandolo verso una pienezza di significazione ch’è la risposta alla prima delle domande della storia: «Adamo, dove sei?» (Gen 3,9). Per poter dire, in calce ad una vita, di non aver vissuto invano: il vero Nobel.
(da Il Mattino di Padova, 16 ottobre 2016)



