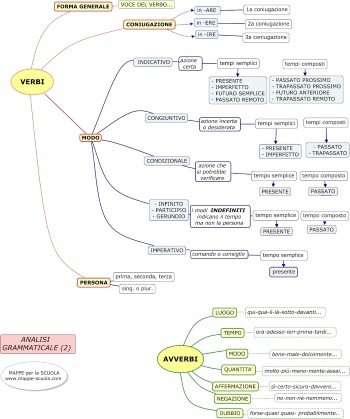 Ci possono essere due modi per leggere una notizia, forse anche di raccontarla: un modo diabolico e un modo simbolico. Raccontare una notizia in modo diabolico significa esporla vivisezionandola nei minimi particolari, denudarla fino all’osso, analizzarla come se non facesse parte di un discorso più ampio: somiglia tanto all’analisi grammaticale che s’insegna a scuola. Raccontare una notizia in modo simbolico, invece, significa leggerla un po’ più dall’alto, con una visuale d’insieme, tenendola legata al suo contesto. S’avvicina maggiormente, questa, più all’analisi logica che a quella grammaticale. Non è che il primo modo di raccontare sia corretto e il secondo errato: l’analisi grammaticale stessa, d’altronde, è la base dell’analisi logica. Sono le due architravi della lingua che si sostengono e s’incoraggiano a vicenda.
Ci possono essere due modi per leggere una notizia, forse anche di raccontarla: un modo diabolico e un modo simbolico. Raccontare una notizia in modo diabolico significa esporla vivisezionandola nei minimi particolari, denudarla fino all’osso, analizzarla come se non facesse parte di un discorso più ampio: somiglia tanto all’analisi grammaticale che s’insegna a scuola. Raccontare una notizia in modo simbolico, invece, significa leggerla un po’ più dall’alto, con una visuale d’insieme, tenendola legata al suo contesto. S’avvicina maggiormente, questa, più all’analisi logica che a quella grammaticale. Non è che il primo modo di raccontare sia corretto e il secondo errato: l’analisi grammaticale stessa, d’altronde, è la base dell’analisi logica. Sono le due architravi della lingua che si sostengono e s’incoraggiano a vicenda.
C’è una notizia che smuove le pance in questi giorni: un giudice di sorveglianza di Padova condanna lo stato a risarcire due detenuti (c’è da credere che il numero aumenterà a dismisura) perché costretti a vivere in condizioni inumane. A raccontarla in modo diabolico è la rabbia a prevalere: già il detenuto è l’ultimo brandello d’umanità, figurarsi poi concedergli il lusso della dignità. S’analizzano dunque i particolari: il tipo di violenza, l’efferatezza, la condanna, le tracce lasciate, il dolore delle vittime. Cause, concause, aggravanti e via dicendo. La questione si incancrenisce. La stessa notizia, raccontata in modo simbolico, non cambia il contenuto ma lo legge nel contesto di una questione ben più vasta: quella della dignità umana che anche nel periodo della detenzione va tutelata e garantita. Non è che la rabbia sbollisca o muti il pensiero nei confronti dell’uomo che sbaglia, ma il racconto acquista più i toni civili della discussione che gli slogan tribali della rivalsa. A leggerla in maniera diabolica si può parlare di “buonuscita” che lo stato concede ai criminali. A leggerla in maniera simbolica si può parlare di uno stato che viene avvertito di non poter più agire come magari ha sempre fatto in barba alle più elementari regole di umanità. Che, poi, è anche un invito ad essere coerente nelle sue aspettative: se io architetto lo spazio del carcere per rieducare coloro che verranno detenuti, devo anche assicurare le condizioni minime di possibilità attraverso le quali questi percorsi possano avverarsi. La prima tra tutte le condizioni: uno spazio che mi permetta di vivere, agire, riflettere. Tutto ciò non significa dimenticarsi delle responsabilità di chi ha fallito, tanto meno del dolore di chi ha subito ingiustizie o perdite d’affetti: il male non va mai giustificato. Ricercarne le cause, però, non è da gente imbelle ma da gente d’intelletto che dalla comprensione del male tenta di far progredire una civiltà. Controvento.
Che lo stato s’accorga finalmente di non essere più immune da qualsiasi forma di responsabilità, è una bella notizia al servizio di tutti: come al cittadino viene chiesto di pagare le sue infrazioni nei confronti dello stato, così è altrettanto corretto che sia lo stato a pagare le sue infrazioni nei confronti dei cittadini. Che poi i primi ad essere tutelati siano proprio coloro che hanno tradito la società, è fonte d’imbarazzo e di faticosa accettazione. D’altronde, però, chi – magari più per pubblicità che per convinzione – cita a menadito Francesco e, indirettamente, il Vangelo dovrebbe pur sempre ricordare che quando Dio vuole convertire il mondo parte sempre e solo dalla periferia. Dal carcere, stavolta, che è la periferia più estrema, insopportabile e fastidiosa di una città. Periferia dentro la quale le notizie si possono sempre leggere in due maniere: in modo diabolico o in modo simbolico. Per salvare dall’ambiguità entrambi gli opposti: che la giustizia non diventi tortura e la misericordia non diventi dissolutezza.
(da Il Mattino di Padova, 28 settembre 2014)



