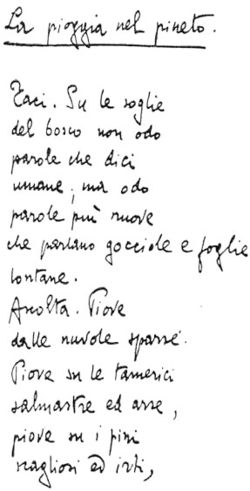 Come un’atavica seduttrice, capace di reggere il trapasso del tempo. Perchè la parola, qualunque essa sia – scritta, testimoniata, narrata, cantata o semplicemente abbozzata -, custodisce nel suo grembo la freschezza di una sorpresa, quasi i lineamenti di un’annunciazione che, raggiungendoti nell’angusto spazio della tua quotidianità, ha la forza di aprire orizzonti inimmaginabili e immergerti in pensieri inediti. Fino quasi a farti abitare possibilità che immaginavi impossibili. La città di Padova in questa settimana ha ceduto al corteggiamento della parola e le ha aperto gli spazi che l’hanno resa grande: il Palazzo Bo, il Teatro Ruzante, il Caffè Pedrocchi, il Conservatorio Pollini, la Sala dei Giganti. Eppoi i luoghi del sapere quotidiano: le scuole, le librerie, le mostre, i musei e i centri culturali. Un trattamento di riguardo per una presenza – quella della parola – che oggi è davvero imbarazzante: un uso irriguardoso di essa ha fatto sì che l’uomo con essa non riesca più a raccontare se stesso, quel sorprendente viaggio di scoperta interiore che l’ha reso unico tra le creature che popolano l’universo. Si parla tanto ma non sempre si comunica altrettanto, perchè non basta fissare la sagoma delle parole: occorre oltrepassare la soglia del loro significato, lasciarsi interpellare da esse, farsi travolgere da una nuova possibilità di immaginare se stessi dentro il mondo. E’ la magnificenza di coloro che sono definiti artisti della parola: racchiudere nello spazio infinitesimale di una sillaba – talvolta addirittura di uno spazio muto e buio – una densità di conoscenza, un corollario di accadimenti che altrimenti non basterebbe una vita intera per poterne fare esperienza.
Come un’atavica seduttrice, capace di reggere il trapasso del tempo. Perchè la parola, qualunque essa sia – scritta, testimoniata, narrata, cantata o semplicemente abbozzata -, custodisce nel suo grembo la freschezza di una sorpresa, quasi i lineamenti di un’annunciazione che, raggiungendoti nell’angusto spazio della tua quotidianità, ha la forza di aprire orizzonti inimmaginabili e immergerti in pensieri inediti. Fino quasi a farti abitare possibilità che immaginavi impossibili. La città di Padova in questa settimana ha ceduto al corteggiamento della parola e le ha aperto gli spazi che l’hanno resa grande: il Palazzo Bo, il Teatro Ruzante, il Caffè Pedrocchi, il Conservatorio Pollini, la Sala dei Giganti. Eppoi i luoghi del sapere quotidiano: le scuole, le librerie, le mostre, i musei e i centri culturali. Un trattamento di riguardo per una presenza – quella della parola – che oggi è davvero imbarazzante: un uso irriguardoso di essa ha fatto sì che l’uomo con essa non riesca più a raccontare se stesso, quel sorprendente viaggio di scoperta interiore che l’ha reso unico tra le creature che popolano l’universo. Si parla tanto ma non sempre si comunica altrettanto, perchè non basta fissare la sagoma delle parole: occorre oltrepassare la soglia del loro significato, lasciarsi interpellare da esse, farsi travolgere da una nuova possibilità di immaginare se stessi dentro il mondo. E’ la magnificenza di coloro che sono definiti artisti della parola: racchiudere nello spazio infinitesimale di una sillaba – talvolta addirittura di uno spazio muto e buio – una densità di conoscenza, un corollario di accadimenti che altrimenti non basterebbe una vita intera per poterne fare esperienza.
Le parole sono frecce appuntite: trafiggono l’anima di un lettore fin quasi a renderlo inquieto e turbato, insonne e pensieroso, frastornato e consolato. Hanno la forza di un tuono che “saetta fiamme di fuoco, scuote la steppa, scuote il deserto di Kades, fa partorire le cerve e spoglia le foreste” (Sal 29). A volte basta l’interstizio di una parola per risolvere questioni che si protraevano da tempo. Come basta l’intermezzo di una parola – magari nella sua veste di offesa o di denigrazione – per innalzare barriere o muri che reggeranno per secoli interi. Quando le parole non parlano più, diventano chiacchiera: somigliano a quelle farfalle bellissime infilzate nei musei che non svolazzano più, a delle meduse senza vertebre, ad un qualcosa che narra di avvenimenti lontani non più capaci di parlare al cuore della gente. Riaprire il salotto di una città per ospitare la parola significa ammettere una nostalgia mal celata: quella di una città che divenga sempre più laboratorio di pensiero, di una produzione letteraria che sia lo specchio di un vissuto, quella di lezioni dove la parola torni ad essere la regina incontrastata. Dell’umanizzazione a scapito della barbarie.
Tante parole sposate tra di loro fanno una canzone, una poesia, una pagina di letteratura. Sono biglietti da visita di spazi umani altrimenti difficili da raccontare, di critiche serrate mai digerite da nessuna dittatura: quelle religiose e quelle politiche (di destra e di sinistra) hanno sempre temuto l’imprevedibilità ammaliante della parola. Fino a riservarne la sua tortura, ovvero la cesura. Eppure dietro ogni parola ci sta una traiettoria: quella dell’esistenza di chi scrive. Fin quasi a sospettare che parole vuote portino la firma di esistenza vuote; che parole dense di significato rechino traccia di personalità d’alto spessore umano; che parole tormentate e tormentose rispecchino l’animo inquieto di chi, toccato da una parola, s’è messo a risalire alle sorgenti della parola stessa. Fino a fare delle parole la fisionomia di un’esistenza stessa, dal momento che si scrive come si vive: da barbari o da gentiluomini.
(da Il Mattino di Padova, 13 ottobre 2013)



