Emanuele (nome in codice) nasce il 6 maggio di 42 anni fa nella splendida terra di Sicilia. Il 6 maggio di ventuno anni fa per lui si spalancarono le porte del carcere: la sua vita, al pari di ogni ergastolano, è un binario morto da abitare giorno dopo giorno senza soccombere alla disperazione. Venti anni e mezzo trascorsi nelle celle delle galere di mezza Italia con il regime punitivo del 41/bis, il “carcere duro” riservato a chi appartiene alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
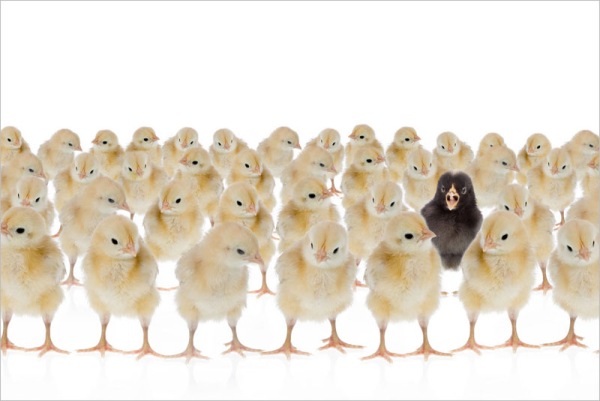
Non tiene famiglia Emanuele, c’è solo una madre là fuori dalle sbarre che lo sta aspettando. E che l’aspetterà fino in punto di morte perchè “attendere” è un verbo che si coniuga meglio al femminile che al maschile. Quella donna si è sorbita migliaia di chilometri per i colloqui, decine di cambi di stagione, intemperie e speranze, grandinate e attese. Per più di vent’anni ha parlato con quell’unico suo figlio da dietro il vetro di un’anonima sala colloqui, nemmeno la possibilità di toccare quella carne, di carezzare quella barba, di stringere quelle mani nate e cresciute nel suo grembo di donna e di madre. Dall’altra parte c’era un figlio che avrebbe voluto pure lui toccare, stringere, abbracciare: anche i lupi – qualora lo fossero per davvero – hanno un cuore che batte. Il 6 maggio di quest’anno ad Emanuele viene tolto il 41/bis e sbarca nel carcere di Padova: carcere altrettanto duro ma almeno i colloqui li farà seduto attorno ad un tavolino. Lunedì scorso sono entrato nella sua cella che, da buon ergastolano, rimarrà per tutta la vita il suo punto di osservazione sul mondo. L’ho visto col volto disteso, sorridente, amabile nella sua tremenda fatica di uomo condannato ad una morte lentissima. “Sono felice don – mi ha confidato con un trasparente sorriso – tre giorni fa ho fatto il colloquio con mia mamma. Non immagini l’emozione che ho provato”. Ha ragione Emanuele: nessuno immagina l’emozione di toccare una madre dopo vent’anni, di sentire il profumo di quella carne ch’è la tua carne, d’avvertire il peso di quel respiro silenzioso che se potesse parlare ti racconterebbe l’altra faccia della vita. Per due ore la madre se l’è baciato quel figlio, se l’è stretto forte, l’ha coccolato al pari di ogni mamma: seppur brigante per la giustizia, per la madre è rimasto un figlio da amare. Poi è partita la sera stessa per la Sicilia, nascondendo la sua emozione e malinconia dentro un vagone letto di un anonimo treno. Ho contemplato Emanuele mentre parlava a strattoni, mentre mi raccontava l’emozione di quegli attimi attesi quasi 8000 giorni, mentre si asciugava qualche lacrima intrattenibile. Poi prima di uscire mi fa una confidenza, come un bambino colto da un improvviso rossore sul volto: “sono tre giorni che non mi lavo il viso. Non voglio perdere il profumo di mia madre che è rimasto sul collo”.
Dentro la disperazione più cupa, dentro il ventre delle galere più orribili, dentro l’abisso della malvagità c’è solo un’essenza che regge il peso della battaglia contro la morte: il profumo di una donna. Se poi quella donna porta il nome di una madre allora quel profumo ha un qualcosa di speciale. Perchè le mamme sono diventate speciali il giorno stesso in cui Dio – finissimo intenditore di bellezze – s’è scelto una donna di Galilea per dare una pista d’atterraggio al suo Figlio, quell’unigenito che Lui amava. La mamma di Emanuele ha lasciato la fragranza di un profumo sul collo del suo amato figlio. Maria di Nazareth ad ogni donna ha lasciato impresso il segreto di quel profumo: amare l’uomo quando meno se lo merita. Forse quello è il momento nel quale ha più bisogno.
Il profumo di una madre: quanto basta per dire loro grazie di non essersi ancora stancate di lottare. Facendo troppe volte le veci pure dell’uomo.




